
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Indice dei contenuti
- Il corpo umano come ecosistema
- Il microbiota intestinale è influenzato dall’età.
- Microbiota e cambiamenti climatici
- Asse intestino-cervello
- Concetto di olobionte
- La visione olistica
- Connessioni microbiota intestinale – cervello
- Il nervo vago: ponte diretto tra cervello e intestino
- Asse vascolare intestino – cervello
- Allora, chi governa il corpo umano?
- Fonti
Il corpo umano come ecosistema
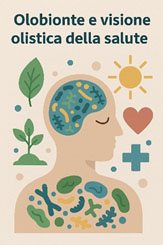 Il corpo umano è affollato da milioni di miliardi di microrganismi, tra batteri, archaea, virus, funghi e protozoi, che vivono in simbiosi con il corpo umano, influenzando la vita quotidiana, le abitudini, i livelli di energia e le patologie.
Il corpo umano è affollato da milioni di miliardi di microrganismi, tra batteri, archaea, virus, funghi e protozoi, che vivono in simbiosi con il corpo umano, influenzando la vita quotidiana, le abitudini, i livelli di energia e le patologie.
Questi microrganismi risiedono in diverse aree del corpo, tra cui la pelle, il cavo orale, i polmoni e altre sedi del corpo e, in particolare, l’intestino, dove formano il microbiota intestinale. Il microbiota intestinale, in particolare, è considerato un vero e proprio organo “aggiunto” con funzioni essenziali per la salute dell’organismo, tra cui:
- metabolismo:aiuta nella digestione di fibre e sostanze che l’organismo non può degradare da solo.
- sistema immunitario:modula le risposte immunitarie e aiuta a proteggere da agenti patogeni.
- salute mentale:interagisce con il sistema nervoso, influenzando potenzialmente l’umore e la risposta allo stress, attraverso l’asse intestino-cervello.
Il microbiota è fondamentale per la salute e il benessere generale, e la sua alterazione può contribuire a diverse malattie. In definitiva, il microbiota rappresenta un ecosistema complesso e dinamico di microrganismi che interagisce in modo significativo con il nostro corpo, influenzandone la salute e il benessere. Il microbiota umano è un buon esempio di mutualismo: cooperazione tra differenti tipologie di organismi che apporta un vantaggio a ognuna di esse. Con microbiota si intende l’insieme di microrganismi vero e proprio, mentre con il termine microbioma si fa riferimento al patrimonio genetico del microbiota.
Negli esseri umani si stima che il microbiota sia composto da circa 10-100 trilioni di cellule microbiche (circa 10 volte in più rispetto al numero di cellule umane) e che contenga >1000 specie batteriche e 100 volte più geni rispetto al totale dei geni contenuti nel genoma umano. I microorganismi più numerosi dei quali sono batteri, ma anche misura inferiore miceti e virus. Tra i batteri la maggioranza è anaerobica, più o meno stretta o facoltativa (molti sopravvivono in assenza di ossigeno e alcuni ne tollerano la presenza). Il batterio intestinale più conosciuto nell’uomo è l’Escherichia coli. Il microbiota umano si sviluppa nel corso dei primi giorni di vita e sopravvive, salvo in caso di malattie, sorprendentemente a lungo.
Nel nostro corpo, il microbiota si trova non solo nell’intestino, ma anche sulla pelle, sui capelli, nella cavità orale, nei polmoni, negli organi genitali (vagina), nelle narici, nella cavità oculare e nel canale uditivo.
Il microbiota intestinale è il più esteso (rappresenta circa il 70% del totale): qui vivono oltre 400 specie differenti di microrganismi. Il microbiota di ogni individuo è esclusivo e rappresenta, quindi, una vera e propria impronta biologica, capace di contraddistinguerci gli uni dagli altri.
Il microbiota intestinale è composto da batteri buoni (ad esempio Bifidobatteri e Lactobacilli) e da batteri cattivi (ad esempio Enterococcus faecalis e Clostridium difficile). È fondamentale per la salute del nostro corpo che i microrganismi buoni e cattivi vivano in equilibrio (condizione definita eubiosi). In condizioni di equilibrio il microbiota favorisce digestione e assorbimento dei nutrienti, produce vitamine e acidi grassi a catena corta (SCFA), sostiene il sistema immunitario, ha comunicazioni ottimali con il cervello. Se questo equilibrio viene alterato, si instaura uno stato di disordine (definito disbiosi) caratterizzato da uno stato cronico di infiammazione che è correlato non soltanto a malattie dell’apparato digerente, ma anche a diabete e obesità, allergie (dermatite), malattie cardiovascolari, neurologiche, psichiche (alterazioni umore, sonno, attenzione, stress) ed oncologiche, solo per citarne alcune.
Ogni individuo possiede il suo proprio microbiota, i ricercatori dell’INRA hanno messo in evidenza l’esistenza di un piccolo numero di specie condivise da tutti che costituirebbero il nucleo filogenetico del microbiota intestinale umano.
Il numero di geni totale del microbiota è stimato essere 100 volte il numero di geni del genoma umano.
Il microbiota intestinale è influenzato dall’età.
Il microbiota nelle prime fasi di vita è costituito da pochi microrganismi, essenzialmente quelli ereditati dalla mamma con il parto. Il tipo di parto (naturale o cesareo) influenza la sua composizione. Dopo la nascita il microbiota cambia, diventando più sensibile ad agenti esterni, come l’alimentazione ed i farmaci, e diventando arricchito soprattutto dei Bifidobatteri, in grado di digerire il latte, di sintetizzare vitamine importanti come il folato e di stimolare il sistema immunitario ancora immaturo, senza però attivare uno stato di infiammazione rilevante. Questi microrganismi danno inizio alla colonizzazione dell’intestino, aumentando di numero poi con l’allattamento e con lo svezzamento. Il microbioma intestinale del bambino inizia così a svilupparsi, fino a quando intorno ai 2-3 anni, inizia a subire delle trasformazioni che lo portano ad assomigliare sempre più a quello di un adulto, caratterizzato da una struttura molto complessa, composta da un numero elevato di microrganismi che coesistono in equilibrio tra di loro.
Negli anziani il numero e l’abbondanza dei microrganismi contenuti nell’intestino diminuisce, minacciando la preziosa condizione di “eubiosi”. Questa riduzione è spesso associata a cambiamenti nell’alimentazione e nello stile di vita che sopraggiungono con l’avanzare dell’età: il calo di appetito, le difficoltà nella masticazione, l’assunzione di farmaci e la riduzione dell’attività fisica possono essere fattori associati a questi cambiamenti.
Altri fattori che influenzano il microbiota intestinale di un individuo sono il suo patrimonio genetico, il luogo in cui vive, l’alimentazione, lo stress, l’uso di farmaci (come, ad esempio, i farmaci a base di cortisone, gli inibitori di pompa protonica, gli antibiotici), la scarsa attività fisica, le infezioni, le allergie, il fumo e l’alcol.
Microbiota e cambiamenti climatici
Il cambiamento climatico non è solo una questione ambientale, ma rappresenta una minaccia diretta per la salute umana, incidendo profondamente anche sul microbiota intestinale. Un recente studio pubblicato su The Lancet Planetary Health da Elena Litchman, ecologa alla Michigan State University, mette in luce infatti come fattori climatici – dall’aumento delle temperature agli eventi estremi come siccità e inondazioni – possano alterare la disponibilità e la qualità del cibo, modificando la dieta in modo negativo. La scarsità di risorse alimentari spinge molte popolazioni verso il consumo di cibi ultraprocessati, spesso più economici ma poveri di nutrienti e dannosi per l’equilibrio del microbiota. Questi alimenti industriali, ricchi di zuccheri, grassi e additivi, peggiorano la salute intestinale, riducendo la diversità microbica e la produzione di acidi grassi benefici.
Parallelamente, il riscaldamento globale compromette anche la qualità dei cibi freschi: l’aumento della CO₂ accelera la crescita delle piante ma ne riduce il contenuto di proteine, ferro e zinco; il riscaldamento degli oceani diminuisce la quantità di omega-3 nei pesci; frutta e verdura diventano più povere di vitamine e antiossidanti; e perfino la struttura delle fibre in cereali e legumi – fondamentali per nutrire il microbiota – viene alterata, ostacolando la fermentazione intestinale. Secondo Carlotta De Filippo del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), tutto ciò può portare alla cosiddetta “fame nascosta”, ovvero una carenza di micronutrienti essenziali in alimenti che sembrano sufficienti dal punto di vista calorico; di conseguenza, le carenze dell’organismo, combinate con specifici disturbi metabolici, aumentano la vulnerabilità alle infezioni da microbi e virus.
Queste dinamiche non colpiscono solo i Paesi più vulnerabili, ma anche le regioni occidentali, dove, ad esempio, la siccità sta già modificando le coltivazioni tradizionali, rendendone alcune insostenibili. Per affrontare questa complessa emergenza sanitaria e ambientale, gli esperti propongono un approccio integrato “One Health”, che unisca climatologia, agronomia, medicina e matematica per prevedere i cambiamenti futuri e sviluppare soluzioni come l’introduzione di colture resilienti, capaci di adattarsi ai nuovi scenari climatici e nutrizionali.
Concetto di olobionte
Il cervello ed il sistema nervoso intestinale sono reciprocamente collegati tramite una fitta e complessa rete di comunicazione che consente l’invio di segnali elettrici dall’intestino al cervello e viceversa. Oltre a questa connessione diretta, cervello ed intestino comunicano tramite il torrente circolatorio, attraverso il rilascio di ormoni e di molecole prodotte dal microbiota intestinale (come, ad esempio, acidi grassi a catena corta, neurotrasmettitori, vitamine). Attraverso questi collegamenti, il cervello controlla le funzioni dell’intestino e, a sua volta, l’intestino può alterare le funzioni del cervello. Se i batteri buoni del microbiota intestinale non sono più in grado di controllare i batteri cattivi si sviluppa la disbiosi: la barriera intestinale diventa permeabile e non riesce più a bloccare i batteri nocivi e le sostanze tossiche e dannose, che, quindi, entrano nel torrente circolatorio, si diffondono nell’organismo e possono raggiungere il cervello, alterandone significativamente le sue funzioni.
Un malfunzionamento nella comunicazione tra l’intestino ed il cervello contribuisce ad una vasta gamma di malattie neurologiche, tra cui l’epilessia, l’ictus, il morbo di Alzheimer, il morbo di Parkinson, e può peggiorare le disfunzioni neurologiche conseguenti al trauma cranico.
Negli ultimi anni, alcuni biologi c.d. evoluzionisti hanno coniato un termine, olobionte, per ridefinire l’organismo vivente alla luce della convivenza con il proprio microbiota. Lynn Margulis, la microbiologa che ha sviluppato negli anni ’60 la teoria dell’endosimbiosi, è la stessa che ha introdotto, a inizio anni ’90, il concetto di olobionte. Ciascun organismo eucariote infatti (animale, vegetale o fungino) da sempre vive in simbiosi con miliardi di microorganismi appartenenti agli altri due regni della vita: batteri e archaea.
Il termine olobionte (dal greco hólos, “tutto”, e bíos, “vita”) descrive l’insieme di un organismo ospite (es. l’uomo) e di tutti i microrganismi che vivono in simbiosi con lui, come batteri, virus, archei, funghi e protisti. È un concetto ecologico e sistemico: l’organismo e il suo microbiota formano un’unica unità funzionale ed evolutiva.
Secondo la versione ortodossa della teoria dell’evoluzione, soltanto i geni, e le loro mutazioni, costituiscono la materia prima per la variazione degli organismi, mentre le relazioni ecologiche selezionano le varianti che meglio si adattano all’ambiente in quel dato momento. Esiste tuttavia una corrente eterodossa, ma non meno autorevole, di biologi convinti che l’esclusiva della variazione non debba spettare ai soli geni. Se l’organismo è un olobionte, il suo genoma sarà un ologenoma, ovvero l’insieme del genoma dell’organismo ospite (uomo o tilapia che sia) e del genoma dei microrganismi che lo abitano. Non solo. Se davvero questi genomi si comportano come una cosa sola, l’ologenoma deve essere considerato un’unità di selezione, ovvero un unico bersaglio della selezione naturale, e in quanto tale evolve come un unico individuo.
I critici sono convinti che l’idea dell’ologenoma come unità di evoluzione non sia necessaria: è sufficiente dire che l’organismo ospite funge da ambiente di selezione per il microbiota, filtra le varianti a lui favorevoli e tanto basta. Il fenomeno osservato verrebbe dunque spiegato da strumenti già presenti nella cassetta degli attrezzi della teoria evoluzionistica, come le dinamiche co-evolutive o quelle simbiotiche tra due o più organismi.
La visione olistica
La medicina olistica ha una visione dell’uomo come essere intero, unico, non frazionabile in parti. È un microcosmo all’interno di un macrocosmo, la natura di cui fa parte. È proprio il termine olismo, coniato nel 1926 dal politico e filosofo sudafricano Jan Smuts, ad indicare quella tendenza della natura a raggruppare in maniera organica ogni settore della realtà in sistemi strutturali complessi, aventi proprietà qualitativamente nuove rispetto a quelle che deriverebbero dalla mera somma delle caratteristiche degli elementi di cui sono composti. L’approccio olistico alla salute considera l’essere umano come un sistema integrato di corpo, mente e spirito, e mira a trattare le cause alla base dei disturbi anziché semplicemente i sintomi che si manifestano. Pertanto, la visione olistica dell’organismo umano vede l’individuo come un’unità indivisibile di corpo, mente e spirito, in cui le diverse componenti interagiscono e si influenzano reciprocamente. Non si tratta di una somma di parti, ma di un sistema complesso in cui ogni elemento contribuisce al benessere generale. In dettaglio, la concezione olistica:
- Considera l’individuo nella sua interezza: Corpo, mente e spirito sono visti come elementi interconnessi e inseparabili, che interagiscono e si influenzano a vicenda.
- Sottolinea l’importanza dell’equilibrio: Il benessere deriva dall’armonia tra le diverse componenti dell’individuo e tra l’individuo e il suo ambiente.
- Promuove l’autoguarigione: L’approccio olistico mira a stimolare le naturali capacità di guarigione dell’organismo, piuttosto che limitarsi a sopprimere i sintomi.
- Valuta la persona nella sua unicità: Ogni individuo è considerato nella sua specificità, tenendo conto del suo contesto di vita, delle sue esperienze e del suo stile di vita.
- Integra diverse discipline: La visione olistica può includere diverse terapie e approcci, sia fisici che mentali, per promuovere il benessere generale.
In pratica, nella cura di una persona, un approccio olistico considera non solo i sintomi fisici, ma anche i fattori psicologici, emotivi e ambientali che possono contribuire alla condizione del paziente. Ad esempio, se una persona soffre di mal di schiena, un approccio olistico potrebbe considerare non solo la causa fisica del dolore, ma anche il suo stato emotivo, il suo stile di vita e il suo ambiente di lavoro.
In sintesi, la concezione olistica dell’organismo umano offre una visione più ampia e integrata della salute, sottolineando l’importanza dell’equilibrio e dell’interconnessione tra corpo, mente e spirito per il raggiungimento del benessere
Connessioni microbiota intestinale – cervello
Il benessere del nostro intestino ha un diretto effetto sulla salute di tutto l’organismo. In particolare, c’è una reciproca influenza tra microbiota e cervello: i batteri e i segnali intestinali modulano l’attività cerebrale; allo stesso modo, il cervello è in grado di modificare l’equilibrio del microbiota mediante sostanze chimiche e ormoni che agiscono direttamente a livello intestinale. Esiste pertanto un complesso sistema di comunicazione bidirezionale intestino-cervello che influenza sia la salute intestinale che quella cerebrale. La comunicazione coinvolge:
- Sistema nervoso enterico: Il microbiota intestinale comunica con il cervello attraverso il sistema nervoso enterico (SNE), una rete di neuroni nel tratto gastrointestinale, che invia segnali al cervello tramite il nervo vago.
- Ormoni e citochine: Il microbiota intestinale può influenzare la produzione di ormoni e citochine, molecole che regolano le funzioni corporee e possono attraversare la barriera emato-encefalica, raggiungendo il cervello.
- Barriera emato-encefalica: La barriera emato-encefalica (BEE) è una unità anatomico-funzionale realizzata dalle particolari caratteristiche delle cellule endoteliali che compongono i vasi del sistema nervoso centrale; ha principalmente una funzione di filtro e protezione del tessuto cerebrale dagli elementi potenzialmente nocivi presenti nel sangue, pur tuttavia permettendo il passaggio di sostanze necessarie alle funzioni metaboliche ed al sistema enterocettivo. La BEE può essere influenzata dalla composizione del microbiota intestinale, da fattori ambientali e patologici.
Implicazioni per la salute:
- Salute mentale: Studi indicano che il microbiota intestinale può essere coinvolto in disturbi dell’umore come ansia e depressione. Alterazioni nel microbiota possono influenzare la produzione di neurotrasmettitori, come la serotonina, coinvolta nella regolazione dell’umore.
- Malattie neurodegenerative: Si ipotizza che il microbiota intestinale possa svolgere un ruolo nello sviluppo di malattie neurodegenerative, come il morbo di Parkinson, influenzando l’infiammazione e la neurodegenerazione.
- Disturbi dello spettro autistico: Alcune ricerche suggeriscono che il trapianto di microbiota intestinale in individui con autismo può portare a miglioramenti nei sintomi e nelle funzioni neurologiche.
In sintesi, il microbiota intestinale è un attore chiave nella salute e nel funzionamento del cervello. Comprendere questa complessa interazione apre nuove prospettive per la prevenzione e il trattamento di disturbi neurologici e neuropsichiatrici.
Il nervo vago: ponte diretto tra cervello e intestino
Il nervo vago è il decimo nervo cranico (nervo X) ed è uno dei più importanti del sistema nervoso parasimpatico. Il suo nome deriva dal latino vagus, che significa “vagante”, perché si estende dal cervello fino all’addome, innervando cuore, polmoni, stomaco, intestino e altri organi. Il nervo vago svolge un ruolo centrale nell’asse intestino-cervello, un sistema di comunicazione bidirezionale tra il sistema nervoso centrale (SNC) e il tratto gastrointestinale, che include anche il microbiota intestinale. Si distinguono
- Vie afferenti (dal corpo al cervello): Circa l’80% delle fibre del nervo vago sono afferenti, cioè trasmettono informazioni dall’intestino al cervello. Queste fibre rilevano segnali meccanici (come la distensione intestinale), chimici (come la presenza di nutrienti o metaboliti) e immunologici (come citochine o molecole infiammatorie).I metaboliti microbici (es. acidi grassi a catena corta, SCFA), neurotrasmettitori (come GABA, serotonina, dopamina, acetilcolina), e peptidi prodotti dal microbiota possono influenzare l’attività vagale.
- Vie efferenti (dal cervello al corpo): Le fibre efferenti del nervo vago regolano funzioni digestive (motilità, secrezione enzimatica, rilascio di bile) e modulano l’attività immunitaria intestinale. Il nervo vago può anche indurre uno stato anti-infiammatorio attraverso il rilascio di acetilcolina (→ “riflesso colinergico anti-infiammatorio”).
Ruolo del nervo vago nell’interazione cervello-microbiota
A. Modulazione neurochimica
- Alcuni ceppi batterici intestinali producono molecole in grado di attivare i recettori del nervo vago. Ad esempio:
- Lactobacillus rhamnosus può modulare il GABA e influenzare l’umore attraverso il nervo vago.
- I cambiamenti nel microbiota possono alterare il tono vagale e quindi influenzare il comportamento, il sonno, lo stress e l’ansia.
B. Effetto sull’umore e sul comportamento
-
- Esperimenti su animali hanno mostrato che la rimozione del nervo vago (vagotomia) blocca gli effetti benefici di alcuni probiotici sul comportamento, indicando che la via vagale è essenziale per la comunicazione tra microbiota e cervello.
C. Ruolo immuno-modulatore
-
- Il nervo vago regola la risposta immunitaria intestinale e controlla l’infiammazione attraverso il “riflesso infiammatorio”.
- Questo è particolarmente rilevante nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (es. colite ulcerosa, Crohn) e in condizioni neuroinfiammatorie (es. depressione, Alzheimer).
Rilevanza clinica: Diete ricche di prebiotici e probiotici possono influenzare positivamente il microbiota, che a sua volta può migliorare il tono vagale e l’equilibrio psico-fisiologico. La fermentazione di fibre da parte del microbiota produce SCFA che stimolano direttamente i recettori vagali.
In sintesi
| Aspetto | Funzione del nervo vago |
| Sensoriale | Raccoglie segnali chimici e infiammatori dall’intestino |
| Motoria | Regola la motilità e la secrezione intestinale |
| Immunitaria | Modula l’infiammazione attraverso il riflesso colinergico |
| Neurocomunicativa | Media la trasmissione di segnali microbici al cervello |
| Psico-emotiva | Implicato nella regolazione dell’umore, ansia, stress |
Asse vascolare intestino – cervello
Nell’intestino è presente la barriera vascolare intestinale (GVB) che connette il corpo con il mondo esterno, agendo come filtro tra quello che mangiamo e il nostro organismo. La funzione principale di questa barriera è permettere l’accesso di nutrienti e piccole molecole nel fegato e nel circolo sanguigno, bloccando invece batteri e sostanze potenzialmente dannose. Una volta che le molecole passano nel circolo sanguigno possono migrare verso qualsiasi organo del corpo, dunque anche nel cervello. In caso di malattie intestinali, come la Malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa, la barriera vascolare dell’intestino (GVB) si disattiva e diventa maggiormente permeabile. Tale malfunzionamento causa la fuoriuscita di mediatori infiammatori e batterici (molecole sintetizzate durante il processo infiammatorio) nel fegato e nel circolo sanguigno.
Nel Sistema Nervoso Centrale (SNC) ci sono due tipi di barriere: la barriera emato-encefalica (BEE) e la barriera emato-liquorale (BEL). La prima ha funzione di protezione del tessuto nervoso dalle sostanze nocive presenti nel sangue ed è continuamente impegnata nel regolare l’ambiente cerebrale (l’omeostasi). La seconda barriera, invece, impedisce il passaggio di sostanze tossiche dal sangue al liquor cerebro-spinale (liquido che permea l’encefalo e il midollo spinale con funzione di protezione). La BEE è costituita da capillari e dal plesso coroideo, una struttura che produce il liquor e svolge un’attività di filtrazione e difesa immunitaria. In determinate condizioni omeostatiche, il tessuto della BEL è permeabile ed è molto meno selettivo della BEE. Un cambiamento nella permeabilità della BEL sarebbe coinvolto nei processi di difesa nervosa dai segnali infiammatori provenienti dell’intestino. Nel plesso coroideo è infatti presente una seconda barriera che integra quella emato-liquorale e definita barriera vascolare del plesso coroideo (PVB); questa connette il cervello con il resto del corpo e si attiva durante uno stato infiammatorio.
Nello specifico, intestino e cervello sarebbero connessi da un asse vascolare: la presenza di un’infiammazione intestinale provoca il malfunzionamento della barriera vascolare dell’intestino (GVB), scatenando la fuoriuscita di mediatori infiammatori e batterici nel sangue attraverso il fegato che arrivano al cervello.
La presenza dei segnali infiammatori nel sangue può essere rilevata dalla fitta rete di capillari e cellule di protezione (come le cellule gliali) del plesso coroideo. Queste strutture regolano la permeabilità dei vasi sanguigni scatenando cambiamenti temporanei delle barriere emato-liquorale e vascolare del plesso coroideo (PVB), mettendo in azione un programma di protezione del cervello che porta alla chiusura della barriera vascolare stessa.
Questo meccanismo di difesa isola il cervello dal resto del corpo ed è responsabile, almeno in parte, delle alterazioni comportamentali (ansia e depressione) e cognitive (deficit di memoria) generalmente descritte dai pazienti con malattie infiammatorie intestinali. Quindi, patologie psichiatriche e cognitive sembrerebbero essere parte della malattia stessa e non solo manifestazioni secondarie.
Allora, chi governa il corpo umano?
La relazione tra cervello e microbiota intestinale, nota come asse intestino-cervello, è un sistema di comunicazione bidirezionale che influenza profondamente il benessere psico-fisico, piuttosto che un semplice rapporto di “chi comanda”. Entrambi, cervello e microbiota, svolgono ruoli cruciali e interagiscono costantemente tra loro, influenzando reciprocamente funzioni e stati d’animo. Ciò non significa che non ci possano essere momenti o fasi in cui l’uno prevalga sull’altro: importante è ripristinare l’equilibrio!
Il microbiota intestinale, spesso chiamato “secondo cervello“, non è un organo di controllo, ma un ecosistema complesso dinamico che comunica con il cervello attraverso diverse vie. Queste includono:
- Il sistema nervoso enterico: Un sistema nervoso autonomo presente nella parete intestinale che può inviare segnali diretti al cervello.
- Il sistema immunitario: Il microbiota intestinale interagisce con il sistema immunitario, che a sua volta può influenzare il cervello.
- Il sistema endocrino: Il microbiota produce molecole che possono agire come ormoni e influenzare il cervello attraverso il flusso sanguigno.
- Il sistema nervoso centrale: Il cervello può influenzare il microbiota attraverso il rilascio di ormoni, neurotrasmettitori e altre sostanze chimiche che arrivano all’intestino.
Il cervello, a sua volta, influenza l’equilibrio del microbiota intestinale attraverso il rilascio di ormoni, neurotrasmettitori e altre sostanze chimiche.
In sintesi, non c’è un organo che “comanda” sull’altro. Il cervello e il microbiota intestinale sono in costante comunicazione, formando un sistema integrato che influenza il nostro benessere fisico e mentale. L’alterazione di questo equilibrio può portare a diversi disturbi, sia a livello intestinale che neurologico.
Fonti
John HT, Thomas TC, Chukwuebuka EC, Ali AB, Anass R, Tefera YY, Babu B, Negrut N, Ferician A, Marian P. The Microbiota-Human Health Axis. Microorganisms. 2025 Apr 20;13(4):948. doi: 10.3390/microorganisms13040948. PMID: 40284784; PMCID: PMC12029893. Litchman E. Climate change effects on the human gut microbiome: complex mechanisms and global inequities. Lancet Planet Health. 2025 Feb;9(2):e134-e144. doi: 10.1016/S2542-5196(24)00332-2. PMID: 39986317. Calder PC, Carr AC, Gombart AF, Eggersdorfer M. Optimal Nutritional Status for a Well-Functioning Immune System Is an Important Factor to Protect against Viral Infections. Nutrients. 2020 Apr 23;12(4):1181. doi: 10.3390/nu12041181. PMID: 32340216; PMCID: PMC7230749. Kokou F, Sasson G, Nitzan T, Doron-Faigenboim A, Harpaz S, Cnaani A, Mizrahi I. Host genetic selection for cold toler ance shapes microbiome composition and modulates its response to temperature. Elife. 2018 Nov 20;7:e36398. doi: 10.7554/eLife.36398. PMID: 30454554; PMCID: PMC6277203
In questo portale:
- L’Intestinimonas butyriciproducens può regolare il microbiota
- Scheda Educativa: Gli Acidi Grassi a Catena Corta (SCFA) e il Microbiota Intestinale
- L’attività fisica aumenta la diversità del microbiota intestinale e può ritardare l’insorgenza di malattie croniche e migliorare la salute generale
- Una zuppa antinfiammatoria per il benessere del microbiota
- Microbiota intestinale sano in “corpore sano”
- Il microbiota del liquido seminale potrebbe avere effetti sulla fertilità maschile
- Il microbiota intestinale potrebbe svelare quanto siamo longevi
- Il microbiota intestinale
- Composizione del microbiota e phyla batterici principali
- Formazione del microbiota – Dinamismo evolutivo dell’ecosistema intestinale
- Intestino, microbiota e infiammazione cronica di basso grado
- Microbiota e rete neuroimmmunoendocrina
- Quadro sinottico microbioma-microbiota
- I dolcificanti artificiali alterano il microbiota: meglio evitarli
- La cellulosa acetilata come prebiotico per regolare il metabolismo dei carboidrati
- L’asse bidirezionale intestino-cervello
- Le fonti proteiche sembrano avere effetti importanti sia sulla popolazione che sulla funzione del microbioma intestinale del topo.
- Importanza dei primi 1000 giorni di vita per la salute futura del bambino
- Effetti dell’estrazione di succhi di frutta e verdura sulla composizione del microbioma
- Non siamo solo individui, ma ecosistemi intricatamente connessi al mondo microbico dentro di noi
- Il microbioma potrebbe mediare l’associazione tra bevande zuccherate e diabete.




