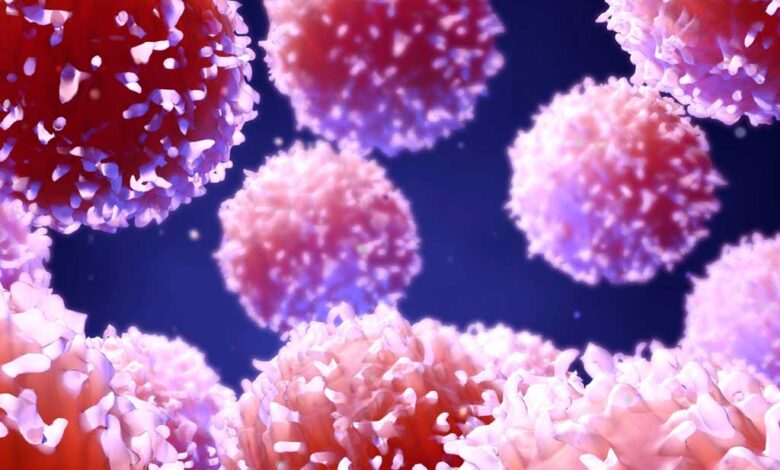
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Le cellule chiave dell’infiammazione sono i fagociti (neutrofili e macrofagi) che fagocitano patogeni, i mastociti che rilasciano mediatori come l’istamina e le prostaglandine, e le cellule endoteliali che regolano il passaggio delle cellule dai vasi sanguigni ai tessuti. Altre cellule includono i linfociti (come i T helper e B) che mediano risposte più specifiche (come la produzione di anticorpi da parte delle plasmacellule), le cellule dendritiche, che reclutano altre cellule e producono mediatori chimici, le piastrine che partecipano all’emostasi e rilasciano mediatori infiammatori, e i fibroblasti che intervengono nella riparazione tissutale.
Cellule immunitarie principali
- Neutrofili: Sono i “primi a rispondere” all’insulto, migrano rapidamente verso il sito dell’infiammazione, fagocitano e distruggono i microrganismi e muoiono formando il pus.
- Macrofagi: Derivano dai monociti e sono presenti in tutti i tessuti. Oltre a fagocitare i patogeni, secernono citochine (come il TNF-α) che reclutano altre cellule immunitarie e svolgono un ruolo chiave nell’infiammazione cronica. Esistono sottotipi pro-infiammatori (M1) e antinfiammatori/riparatori (M2).
- Mastociti: Si trovano nei tessuti connettivi e contengono granuli con sostanze come l’istamina. Il rilascio di queste sostanze causa la dilatazione dei vasi e l’aumento della permeabilità nella fase acuta.
-
Linfociti: I linfociti B si differenziano in plasmacellule che producono anticorpi; i linfociti T helper (TH) producono citochine che attivano altre cellule.
- I linfociti TH1 sono un sottotipo di linfociti T helper (CD4+) che svolgono un ruolo cruciale nell’immunità cellulare, coordinando l’attivazione dei macrofagi e dei linfociti T citotossici per contrastare infezioni da patogeni intracellulari come virus e batteri. La loro funzione principale è la produzione di citochine come l’IFN-γ, che stimola i macrofagi a eliminare i microbi e attiva le cellule NK a produrre ulteriore IFN-γ, favorendo così le risposte cellulari. Coadiuvano i linfociti T citotossici (CD8+) e altre cellule immunitarie a combattere le infezioni mediate dalle cellule.
- I linfociti TH17 sono un sottotipo di linfociti T helper che giocano un ruolo cruciale nella difesa contro infezioni batteriche e fungine, soprattutto a livello gastrointestinale, producendo citochine come l’IL-17 che richiamano altre cellule immunitarie e inducono infiammazione locale per eliminare il patogeno. Svolgono un ruolo anche in malattie autoimmuni e infiammazioni croniche, poiché la loro attivazione fuori controllo può scatenare reazioni immunitarie eccessive.
-
I linfociti TH2 svolgono un ruolo fondamentale nel sistema immunitario:
- I Th2 sono cruciali per l’attivazione e differenziazione dei linfociti B, stimolandoli a produrre plasmacellule e anticorpi, in particolare le immunoglobuline E (IgE), che sono coinvolte nelle reazioni allergiche. Le citochine prodotte dai Th2, in particolare l’IL-5, reclutano e attivano gli eosinofili, cellule importanti per eliminare i parassiti elminti (vermi intestinali).
- I Th2 sono strettamente associati all’insorgenza delle malattie allergiche e infiammatorie. Essi producono citochine come
- Interleuchina-4 (IL-4): Promuove la differenziazione dei linfociti B verso la produzione di IgE, inibisce la produzione di interferone-gamma (IFN-γ) e stimola lo sviluppo dei Th2 stessi.
- Interleuchina-5 (IL-5): Stimola la maturazione, l’attivazione e il reclutamento degli eosinofili, rendendoli capaci di combattere i parassiti.
- Interleuchina-13 (IL-13): Coinvolta nell’attivazione dei macrofagi in modalità alternativa, nella produzione di muco e nell’induzione di risposte infiammatorie e allergiche.
-
-
- I Th2 influenzano altri aspetti del sistema immunitario, come l’attivazione dei mastociti e la produzione di muco nelle vie respiratorie.
-
Ruolo nello switch Th1/Th2: La ripartizione tra i diversi tipi di linfociti T helper, come i Th1 e i Th2, è nota come “switch Th1/Th2“. Un aumento di linfociti Th2 rispetto ai Th1 può portare a un’alterazione dell’equilibrio immunitario, causando un aumento della suscettibilità alle malattie allergiche e influenzando l’attività del sistema immunitario in risposta a diverse infezioni.
- Cellule dendritiche: Fungono da cellule presentanti l’antigene, attivando i linfociti T e rilasciando citochine.
- Eosinofili: Reagiscono a specifici mediatori e sono coinvolti nelle reazioni allergiche e nella difesa contro i parassiti.
Cellule non immunitarie
- Cellule endoteliali:Rivestono i vasi sanguigni e, nel corso dell’infiammazione, aumentano la permeabilità per permettere alle cellule immunitarie e alle proteine di uscire dai vasi e raggiungere il tessuto infetto (extravasazione) attraverso la produzione di molecole di adesione.
- Piastrine: Coinvolte nella coagulazione del sangue, ma rilasciano anche mediatori chimici (come la serotonina) che influenzano l’infiammazione.
- Fibroblasti: Cellule del tessuto connettivo, sono fondamentali per il processo di riparazione e cicatrizzazione dei tessuti dopo l’infiammazione.
Mediatori chimici
-
Citochine: Proteine che attivano e reclutano cellule immunitarie, come neutrofili e monociti, nel sito dell’infiammazione. Le chemochine più studiate sono le chemochine CXCL8 (IL-8) e CCL2 (MCP-1), che reclutano rispettivamente neutrofili e monociti. La loro produzione è indotta da citochine pro-infiammatorie come IL-1, IL-6 e TNF-α, e da segnali microbici o danno tissutale. prodotte da diverse cellule che regolano l’infiammazione. Si riconoscono
-
Citochine pro-infiammatorie
- Interleuchina-1 ( IL−1)): Liberata in risposta a infezioni e stimoli infiammatori, contribuisce all’attivazione delle cellule immunitarie.
- Interleuchina-6 (IL−6): Promuove l’infiammazione acuta e cronica e stimola la produzione di altre molecole infiammatorie come la proteina C reattiva (PCR).
- Fattore di necrosi tumorale-alfa (TNF−α): Una delle citochine più potenti nell’infiammazione acuta, è responsabile di effetti sistemici come febbre, aumento della dilatazione dei vasi sanguigni e può contribuire a effetti patologici se in eccesso.
- Interferoni (IFN): In particolare l’interferone-gamma (IFN−γ), svolge un ruolo fondamentale nella risposta contro i virus e nell’attivazione dei macrofagi.
- Chemochine (es. CCL2): Anche se non sono sempre classificate come “citochine” nel senso stretto del termine, le chemochine sono cruciali perché attraggono le cellule immunitarie (come i monociti) nel sito dell’infiammazione.
- Citochine anti-infiammatorie
-
Citochine pro-infiammatorie
- Interleuchina-4 (IL−4): Ha un ruolo antinfiammatorio, contribuendo a spegnere la risposta immunitaria.
- Interleuchina-10 (IL−10): Sopprime l’attivazione delle cellule immunitarie e la produzione di altre citochine infiammatorie.
- Fattore di crescita trasformante-beta (TGF−β): Media processi di riparazione tissutale e ha effetti inibitori sulla risposta infiammatoria.
-
Chemochine: Molecole prodotte da cellule immunitarie (come macrofagi e cellule dendritiche) e da cellule non immunitarie (come cellule endoteliali, epiteliali e fibroblasti) in risposta a citochine pro-infiammatorie o a segnali di pericolo come agenti patogeni e danno tissutale; attirano specifiche cellule immunitarie verso il sito dell’infiammazione.
- CXCL8 (IL-8): È la principale chemochina che recluta i neutrofili, agendo attraverso i recettori CXCR1 e CXCR2 espressi sulle loro membrane.
- CCL2 (MCP-1): Attira i monociti verso il sito infiammato.
- CXCL10 (IP-10): Coinvolge il reclutamento di cellule T.
- Neuropeptidi: Sostanze vasoattive che giocano un ruolo nell’infiammazione neurogenica e nel dolore; vengono rilasciati localmente dai neuroni afferenti in risposta a vari stimoli. Agiscono su recettori specifici nelle cellule circostanti, come i mastociti, inducendo il rilascio di altri mediatori infiammatori che amplificano il processo infiammatorio e la sensibilizzazione neuronale. Questa sensibilizzazione può portare a condizioni di dolore cronico, come nel caso della cistite interstiziale e dell’endometriosi
- Sostanza P: un neuropeptide che contribuisce all’infiammazione neurogenica e alla sensibilizzazione del dolore.
- CGRP (peptidi correlati al gene della calcitonina): un altro mediatore del rilascio neuronale che partecipa all’infiammazione neurogenica.
- Neurochinina A (NKA): rilasciata dai neuroni afferenti, contribuisce all’infiammazione locale.
- Endotelina-3 (ET-3): anch’essa rilasciata dai neuroni afferenti e coinvolta nel processo infiammatorio.
- Neurotrofina (NGF): è riconosciuta come uno dei principali mediatori del dolore. Stimola la crescita delle terminazioni nervose, amplificando la risposta dolorosa (iperalgesia).
- Oppiodi: i peptidi oppioidi sono neuropeptidi che influenzano il sistema nervoso e le risposte infiammatorie, anche se sono noti principalmente per il loro effetto analgesico.
Marcatori di infiammazione
Gli indici di flogosi, detti anche marcatori di infiammazione o marker infiammatori, sono parametri che contribuiscono determinare la causa di una risposta infiammatoria sistemica e stabilirne l’entità.
Questi valori possono essere misurati nel sangue o in altri liquidi biologici; in ambito clinico, la loro valutazione può essere utile per il medico come campanello d’allarme che indica la presenza di infiammazioni dovute a lesioni, infezioni o specifiche condizioni patologiche.
Oltre ad essere utilizzato come supporto nell’inquadramento diagnostico, il dosaggio degli indici di flogosi presenti viene utilizzato per stabilire la gravità del processo infiammatorio, la prognosi e/o la risposta ad un eventuale trattamento. L’esame dei marker infiammatori viene prescritto, di solito, in associazione ad altri accertamenti diagnostici.
I marcatori infiammatori più comunemente usati sono:
- Proteina C reattiva (PCR): è una delle proteine della fase acuta del processo infiammatorio e viene rilasciata a seguito dello stimolo delle interleuchine IL-6 e IL-8; le sue concentrazioni cambiano rapidamente entro le prime 6-8 ore dopo l’infortunio, raggiungono il picco dopo 48 ore, e tornano a livelli normali una volta risolto il problema.
La proteina C reattiva si riscontra nel sangue delle persone che presentano un processo flogistico di varia origine. La proteina C reattiva è prodotta principalmente a livello epatico, in risposta a stimoli quali agenti nocivi, microrganismi patogeni ed immunocomplessi, ma anche in seguito a traumi. L’aumento della proteina C reattiva si verifica in molte diverse condizioni infiammatorie, tra cui: malattie reumatologiche, come alcune forme di artrite; patologie autoimmuni (es. lupus eritematoso sistemico o vasculiti) che causano infiammazione cronica; infezioni batteriche o virali che causano infiammazione acuta, come la polmonite; malattia infiammatoria intestinale (es. morbo di Chron); traumi.
Esistono due test clinici per la PCR, un test standard e un test ad alta sensibilità (hs-CRP); quest’ultima non dovrebbe essere utilizzata nella valutazione dei processi infiammatori generali, bensì per valutare l’aumento del rischio di malattie cardiovascolari (CVD), essendo considerata un fattore di rischio specifico per queste malattie.
La PCR ha una gamma ristretta di valori normali, di solito inferiori a 3-10 mg/l nel sangue. Nei pazienti con infezioni o condizioni infiammatorie, i livelli di PCR possono aumentare di diverse centinaia di volte. I normali livelli sierici di hsPCR sono indicativamente inferiori a 0,55 mg/L negli uomini e inferiori a 1,0 mg/L nelle donne.
La PCR è correlata ad un altro esame usato per valutare uno stato infiammatorio: il test della velocità di sedimentazione dei globuli rossi (VES). A differenza di quest’ultimo parametro, però, la proteina C reattiva aumenta e diminuisce più rapidamente.
- Velocità di eritrosedimentazione (VES): Questa è un indice infiammatorio che, come suggerisce lo stesso termine, misura la velocità con cui gli eritrociti (globuli rossi) di un campione di sangue – reso incoagulabile – sedimentano sul fondo della provetta che lo contiene. Più velocemente cadono, più è probabile che ci siano alti livelli di infiammazione. Il paramento viene espresso in millimetri di sedimento prodotto in un’ora. La VES è una misura indiretta delle concentrazioni di proteine plasmatiche ad azione pro-infiammatoria ed è influenzata da una serie di stati patologici. Indicativamente, il range normale è di 0-22 mm/h per gli uomini e 0-29 mm/h per le donne. Inoltre, i normali valori di VES sono specifici per età, dal momento che il tasso aumenta costantemente con l’invecchiamento ed è più alto nelle donne rispetto agli uomini.
Molti processi patologici possono determinare un aumento della velocità di eritrosedimentazione: infiammazioni, infezioni di vario genere, anemia ed alcuni processi tumorali.
Occorre precisare che la VES è un indice aspecifico (cioè generico) e deve essere interpretato nel contesto di altre indagini cliniche mirate: risultati elevati indicano spesso la presenza di infiammazione senza indicare al medico esattamente dove è situata l’infiammazione e da cosa è provocata. In altre parole, il riscontro di un valore elevato non deve indurre preoccupazione, se altri parametri risultano nella norma.
Per la corretta interpretazione, la VES è solitamente utilizzata in combinazione ad altri test, come il dosaggio della proteina C reattiva (PCR), gli anticorpi antinucleo (ANA), il fattore reumatoide, il fibrinogeno ed altri esami generici, come il pannello metabolico totale o l’emocromo con formula.
I globuli rossi sedimentano più velocemente in presenza di un’aumentata concentrazione di proteine nel sangue in risposta all’infiammazione, in particolare di quelle chiamate “di fase acuta” (come la proteina C reattiva ed il fibrinogeno).
- Procalcitonina (PCT): La procalcitonina (PCT) è il precursore della calcitonina e viene utilizzato quale un marcatore biologico di sepsi, shock settico e gravi reazioni infiammatorie. A livello plasmatico, il riscontro di valori elevati è fortemente suggestivo di una risposta flogistica ad un’infezione batterica sistemica.
La procalcitonina può essere prodotta da diversi tipi di componenti cellulari e da molti organi in risposta a stimoli pro-infiammatori (es. endotossine batteriche e citochine infiammatorie).
La determinazione della procalcitonina può essere richiesta insieme ad altre indagini di laboratorio, come emocultura, emocromo con formula leucocitaria, analisi del liquor e misura della proteina C-reattiva (PCR).
- Interleuchina-6 (IL-6): è una proteina che agisce come messaggero chimico nel sistema immunitario, regolando le risposte infiammatorie e immunitarie. L’IL-6 viene prodotta da diverse cellule del sistema immunitario e altre cellule, come i fibroblasti e gli adipociti in risposta a infezioni, traumi o danni tissutali, ma livelli elevati possono anche indicare malattie infiammatorie croniche, autoimmuni, cardiovascolari o alcuni tipi di cancro. La misurazione dei suoi livelli nel sangue può aiutare nella diagnosi e nel monitoraggio di queste condizioni. Può indicare la presenza di infiammazioni sistemiche. Livelli elevati sono associati a condizioni come l’artrite reumatoide, il diabete, le malattie cardiovascolari, l’obesità e alcuni tipi di cancro.Stili di vita scorretti: Anche fattori come fumo, stress e carenza di sonno possono contribuire all’aumento dei livelli di IL-6.
- Amiloide sierica A (SAA): La SAA è una proteina chiave nel processo infiammatorio, e la sua misurazione nel sangue aiuta a diagnosticare e valutare condizioni infiammatorie, in particolare in ambito veterinario, ma anche le amiloidosi secondarie nell’uomo. E’ una proteina della fase acuta prodotta dal fegato in risposta a stimoli infiammatori.
Un test SAA misura questa proteina e può indicare la presenza di processi infiammatori, come la peritonite infettiva felina (FIP) nei gatti, ed è usato in ambito veterinario per diagnosticare malattie infiammatorie croniche, tra cui l’amiloidosi AA. In ambito umano, le infiammazioni croniche stimolano il fegato a produrre grandi quantità di SAA, che possono aggregarsi formando fibrille amiloidi e causando l’amiloidosi secondaria (amiloidosi AA). Questa forma di amiloidosi, causata dall’accumulo di amiloide A, è spesso associata a malattie infiammatorie croniche come l’artrite reumatoide, il morbo di Crohn e infezioni come la tubercolosi.
Altri marcatori infiammatori sono valutati, talvolta, in circostanze specifiche. Per esempio:
- Emocromo con formula: i cambiamenti nelle percentuali in cui sono presenti le cellule del sangue e nei parametri a loro associati (es. una conta leucocitaria e piastrinica elevata con un basso livello di emoglobina) possono contribuire a rilevare la presenza di una risposta flogistica in corso. L’emocromo può dare numerose informazioni sullo stato di salute del paziente, ma è considerato un indicatore d’infiammazione aspecifico, poiché ascrivibile a varie malattie, anche molto diverse tra loro, come infezioni, malattie autoimmuni, malattia infiammatoria intestinale e tumori. In altre parole, eventuali alterazioni dei valori dell’emocromo vanno interpretate correttamente dal medico che provvederà a prescrivere esami più approfonditi per stabilire una diagnosi.
- Calprotectina: sostanza presente nei neutrofili, molto attivi nell’infiammazione. La quantità di calprotectina nelle feci può essere utilizzata per distinguere la malattia infiammatoria intestinale da una causa non infiammatoria dei propri sintomi (come la sindrome dell’intestino irritabile).
- Ferritina: proteina essenziale per lo stoccaggio del ferro nell’organismo. Un basso livello di ferritina nel sangue può indicare una carenza di ferro, mentre un alto livello di ferritina nel sangue potrebbe indicare artrite reumatoide, malattie del fegato, ipertiroidismo o altre condizioni infiammatorie.
- Glicoproteina alfa-1-acida: nota anche come orosomucoide, è una proteina prodotta dal fegato, classificata come proteina di fase acuta. Aumenta in risposta a infiammazioni acute, infezioni, traumi, lesioni tissutali, stress, ustioni, malattie autoimmuni e condizioni neoplastiche. Il suo ruolo principale è quello di marcatore per monitorare l’evoluzione di processi infiammatori e può anche legare diverse sostanze nel sangue, come ormoni (es., il progesterone), e altre sostanze basiche e lipoiche, influenzando la loro disponibilità.
- Fibrinogeno: è un fattore essenziale per la coagulazione del sangue, rilasciato in circolo in caso di necessità; quando c’è una ferita ed inizia il sanguinamento, si forma un coagulo attraverso una serie di passaggi (emostasi). In uno degli ultimi step, il fibrinogeno solubile viene convertito in filamenti di fibrina insolubili che si intrecciano tra loro formando una rete che si stabilizza ed aderisce al sito danneggiato fino alla guarigione. I suoi livelli, insieme alle cosiddette proteine di fase acuta (proteina C reattiva, fattori del complemento, protrombina ecc.), aumentano durante processi infiammatori di qualsiasi origine, nella ripresa da un intervento chirurgico e durante la gravidanza.
- Epcidina: è un peptide epatico che agisce come ormone chiave nel regolare l’omeostasi del ferro nel corpo, controllando l’assorbimento intestinale e il rilascio del ferro dai depositi cellulari, in particolare i macrofagi. Agisce legandosi e inibendo la proteina ferroportina, la cui funzione è quella di esportare il ferro dalle cellule nel sangue. Una carenza di epcidina porta a un eccesso di ferro nel corpo (come nell’emocromatosi), mentre un suo eccesso può causare un deficit di ferro, portando ad anemia. Quando i depositi di ferro nel corpo sono elevati o durante stati infiammatori, il fegato produce più epcidina per limitare l’ingresso di nuovo ferro nell’organismo. Se i depositi di ferro sono insufficienti o quando è necessario più ferro per la produzione di globuli rossi, la produzione di epcidina viene inibita, permettendo un maggiore rilascio e assorbimento di ferro.
In ogni caso, occorre ricordare che i risultati di ciascun esame non vanno interpretati da soli, ma sempre alla luce dei risultati di altre analisi, che potranno essere indicate dal medico, di volta in volta.
Molecole di adesione della risposta infiammatoria
Le principali molecole di adesione coinvolte nella risposta infiammatoria sono le selectine (E, P, L), le integrine e le immunoglobuline di adesione, che facilitano l’interazione e la migrazione dei leucociti dal circolo sanguigno ai tessuti colpiti dall’infiammazione. Le selectine sono coinvolte nella fase iniziale di “rolling” dei leucociti, mentre le integrine permettono un’adesione più stabile e la successiva diapedi di attraverso l’endotelio.
Classificazione e funzioni principali:
- Selectine: Mediano l’adesione transitoria e il “rolling” dei leucociti lungo la parete vascolare. Questa fase di arresto è possibile perché le selectine si legano a specifici carboidrati sui loro partner cellulari.
- P-selectina: Espressa sulle cellule endoteliali e sulle piastrine in risposta a mediatori infiammatori come le anafilotossine (es. C5a).
- E-selectina: Espressa sulle cellule endoteliali in seguito all’attivazione da citochine pro-infiammatorie come il TNF-alfa.
- L-selectina: Espressa sui leucociti (linfociti, neutrofili, monociti) e coinvolta nel processo di “homing” (migrazione verso i tessuti linfatici) e nel passaggio attraverso l’endotelio dei tessuti periferici.
- Integrine: Svolgono un ruolo cruciale nell’adesione stabile dei leucociti all’endotelio e nella migrazione attraverso di esso. Le integrine si legano a molecole sulla matrice extracellulare e all’endotelio, permettendo ai leucociti di aderire saldamente e di attraversare la parete vasale (diapedesi). Molte integrine si legano ad esempio, a sequenze specifiche come la sequenza Arg-Gly-Asp (RGD) presente in proteine della matrice come la fibronectina.
- Immunoglobuline di adesione (come le CAM): Funzione: Coinvolte nell’adesione forte e stabile tra cellule endoteliali e leucociti durante la fase di adesione salda. ICAM (Intercellular Adhesion Molecule), ad esempio, che si lega ad altre molecole presenti sui leucociti.
Il processo di migrazione leucocitaria
- Rolling: Le selectine mediano l’interazione debole tra i leucociti e l’endotelio attivato, causando un “rotolamento” dei leucociti lungo la superficie endoteliale.
- Adesione salda: L’attivazione di chemochine e altri segnali provoca un cambiamento conformazionale nelle integrine dei leucociti, che si attivano e aumentano la loro affinità per i ligandi sull’endotelio (come ICAM), portando a un’adesione forte e stabile.
- Diapedesi: I leucociti attraversano lo strato di cellule endoteliali e la membrana basale per raggiungere il tessuto sede dell’infiammazione, guidati da gradienti di chemochine.
Molecole costimolatorie della risposta infiammatoria
Le principali molecole costimolatorie della risposta infiammatoria sono le citochine (come le interleuchine IL-1, IL-6 e il TNF-α), le chemochine (come la IL-8) e le molecole di adesione (come le selectine e le integrine). Queste molecole, prodotte principalmente da cellule immunitarie e cellule endoteliali, sono essenziali per coordinare l’infiammazione, reclutando leucociti nella sede della lesione e attivando la risposta immunitaria.
- Citochine: Proteine solubili che mediano la comunicazione tra le cellule del sistema immunitario e non solo.
-
- Pro-infiammatorie: Come TNF-α e IL-1, inducono le cellule endoteliali a esprimere molecole di adesione e promuovono la risposta febbrile e l’attivazione di altre cellule immunitarie.
- Chemochine: Attirano i leucociti verso la sede dell’infiammazione, agendo come “segnali di richiamo”.
- Molecole di adesione: Proteine che si trovano sulla superficie delle cellule endoteliali e dei leucociti; permettono ai leucociti di aderire all’endotelio vascolare, di “rotolare” sulla sua superficie e di migrare attraverso le pareti dei vasi per raggiungere il tessuto infiammato.
-
- Selectine: Inizialmente permettono un’adesione debole e il movimento di “rotolamento” dei leucociti.
- Integrine: Coinvolte nell’adesione forte e stabile, essenziale per il passaggio dei leucociti nel tessuto.
Altre molecole importanti
- Istamine: Rilasciate dai mastociti, sono responsabili della fase iniziale dell’infiammazione, causando vasodilatazione e aumento della permeabilità vascolare, che contribuiscono a rossore, gonfiore e dolore.
- Proteine della fase acuta: Proteine plasmatiche che vengono rilasciate in risposta alle citochine pro-infiammatorie e partecipano alla risposta immunitaria.




