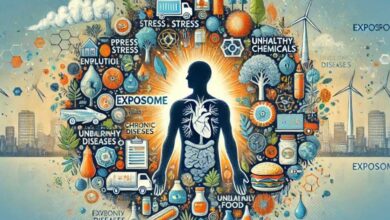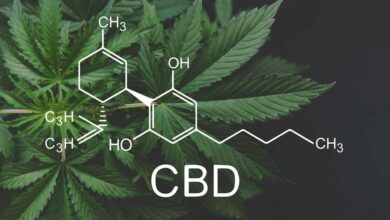Oppioidi, mai abbassare la guardia!
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Gli oppioidi sono essenziali come farmaci per gestire il dolore; se usati però in maniera inappropriata o illegale possono diventare droghe letali.
Si tratta di sostanze chimiche psicoattive che producono effetti farmacologici simili a quelli della morfina. Rappresentano i farmaci analgesici più utilizzati nella medicina moderna per il trattamento del dolore acuto – come quello post-operatorio – o cronico, come nelle patologie oncologiche o nei disturbi dolorosi persistenti.
Si dividono in tre grandi categorie: naturali, semisintetici e sintetici.
- Gli oppioidi naturali, noti anche come oppiacei, derivano direttamente dal papavero da oppio (Papaver somniferum, pianta originaria della Turchia). Sono composti modicamente alterati dal punto di vista chimico rispetto alla molecola progenitrice, la morfina; la maggior parte di queste sostanze sono profarmaci della morfina: diacetilmorfina (morfina diacetato, eroina); nicomorfina (morfina dinicotinata); dipropanoilmorfina (morfina dipropionato); desomorfina; acetilpropionilmorfina; dibenzoilmorfina; diacetildiidromorfina. Tra tutti, la morfina e la codeina, isomero naturale di morfina metilato, sono i più noti e vengono usati da secoli per alleviare la sofferenza umana.
- Gli oppioidi semisintetici sono derivati chimici degli oppiacei naturali; vengono creati in laboratorio modificando la struttura molecolare di sostanze naturali, come l’ossicodone e l’idrocodone, per aumentarne l’efficacia o cambiarne l’azione farmacologica. Tra questi l’eroina (diamorfina), l’ossicodone, l’ossimorfone, l’etilmorfina. l’idromorfone, la buprenorfina e il naloxone, che è il principale antagonista degli oppioidi e può essere fondamentale in situazioni di overdose da altri oppioidi.
- Infine, gli oppioidi sintetici (ad esempio tramadolo, fentanyl, metadone, sufentanil, petidina, levorfanolo, destropropossifene) vengono completamente prodotti in laboratorio, e quindi non derivano direttamente dal papavero. Spesso estremamente potenti perché progettati per potenziare gli effetti degli oppioidi naturali, vengono impiegati principalmente in anestesia o terapia intensiva. Tramadolo e tapentadolo sono delle molecole particolari. Tramadolo è a tutti gli effetti un oppioide e può essere considerato un derivato della codeina. La molecola si comporta come un debole agonista del recettore oppiaceo μ, ma proprio come un classico antidepressivo triciclico, blocca la ricaptazione di serotonina e noradrenalina. Tapentadolo, agonista debole dei medesimi recettori μ, si comporta in modo assolutamente simile.
A questi vanno aggiunti gli oppioidi endogeni prodotti naturalmente dal corpo umano, come le endorfine, le encefaline, le dinorfine e le endomorfine. Morfina ed altri oppiacei, prodotti in minima quantità nel corpo, possono essere inclusi in questa categoria.
Meccanismo d’azione
Gli oppioidi agiscono legandosi e attivando i recettori oppioidi presenti sulle cellule del sistema nervoso centrale e periferico, mimando l’azione degli oppioidi endogeni come le endorfine. L’attivazione provoca una serie di effetti fisiologici, tra cui l’analgesia (riduzione del dolore) a diversi livelli (spinali e sovraspinali), ma anche effetti come la miosi, la depressione respiratoria, la riduzione della motilità intestinale e l’euforia.
Invero l’attivazione di detti recettori porta all’induzione di risposte fisiologiche specifiche, che variano a seconda del tipo di recettore attivato e del livello del sistema nervoso in cui agisce. Esistono tre tipi di recettori:
- Recettori μ (mu): Questi sono il bersaglio principale di sostanze come la β-endorfina. La loro attivazione provoca analgesia sovraspinale, sedazione, miosi, depressione respiratoria, ridotta motilità gastrointestinale ed euforia.
- Recettori κ (kappa): L’attivazione di questi recettori genera analgesia a livello spinale, miosi, depressione respiratoria, disforia e riduzione della motilità intestinale.
- Recettori δ (delta): Non generano un’analgesia significativa, ma influenzano la diminuzione del transito intestinale e la depressione del sistema immunitario. Modulano il rilascio di ormoni e neurotrasmettitori.
I recettori per gli oppiodi si trovano nelle aree del cervello legate alla percezione del dolore, al piacere, alla respirazione e all’umore. Quando vengono attivati, inviano un messaggio chiaro: “non sentire dolore”. È come se il cervello abbassasse il volume della sofferenza. Ma il loro effetto non si limita al sollievo: insieme alla sedazione, gli oppioidi stimolano anche il sistema dopaminergico, il circuito cerebrale della ricompensa, scatenando sensazioni intense di benessere, euforia fino all’estasi.
Ed è proprio questa risposta a renderli insidiosi. Il cervello, come una macchina che impara in fretta, associa quella sensazione al farmaco e inizia a desiderarla ancora. Capita così che, con l’uso frequente e a lungo termine, i recettori diventino meno sensibili: è il fenomeno della tolleranza, che riduce l’effetto analgesico e spinge a cercare dosi sempre maggiori. Nel frattempo, il corpo sviluppa dipendenza fisica, e l’assenza del farmaco può scatenare sintomi di astinenza violenti e dolorosi che possono comportare effetti come sudorazione, ansia, diarrea e anche dolori addominali molto forti.
La dipendenza e la tolleranza si sviluppano velocemente dopo i primi giorni di utilizzo, a seconda delle dosi assunte e delle caratteristiche dei soggetti. È il motivo per cui è fondamentale una riduzione lenta e controllata del dosaggio, sia nei pazienti che assumono oppioidi per brevi periodi sia in chi li usa a lungo termine. In ambito clinico, questa è una prassi imprescindibile per evitare reazioni avverse.
Farmaci oppioidi ordinati secondo la loro capacità analgesica rispetto alla morfina
- Tramadolo e codeina (10 volte meno efficaci della morfina): Sono tra gli oppioidi più deboli in circolazione. Utilizzati per dolori lievi o moderati, presentano un minore rischio di dipendenza ma anche un’efficacia limitata. Spesso sono impiegati come primo approccio al trattamento del dolore.
- Tapentadolo (2,5 volte meno potente della morfina): Più potente dei precedenti, ma comunque meno della morfina. Viene scelto in contesti di dolore moderato.
- Morfina e idrocodone (riferimento base per confrontare tutti gli altri oppioidi): Sono il punto di riferimento clinico. Entrambi vengono usati nel trattamento del dolore severo, sia acuto che cronico. La loro efficacia è ben documentata, ma richiedono un’attenta gestione per evitare effetti avversi o sviluppo di tolleranza.
- Ossicodone (circa una volta e mezza più potente della morfina): Più potente della morfina, è molto usato nella pratica clinica, soprattutto negli Stati Uniti. Tuttavia, è associato a un rischio più elevato di abuso e dipendenza e ha avuto un ruolo centrale nella crisi degli oppioidi.
- Eroina (diamorfina) (è da due a tre volte più potente della morfina): Passata nel giro di circa vent’anni da farmaco da banco a droga altamente pericolosa, l’eroina – o diamorfina – è stata inizialmente commercializzata dalla Bayer alla fine dell’Ottocento col nome di “Heroin”, una forma di diamorfina considerata un analgesico rivoluzionario. Venduta liberamente insieme all’aspirina, ha conquistato rapidamente il mercato grazie al suo potere sedativo e calmante. Ma già nei primi anni del ’900 sono emersi i suoi effetti collaterali devastanti, tra cui lo sviluppo di gravi dipendenze che hanno portato a una diffusione massiccia e incontrollata della sostanza. Dai salotti borghesi alle strade, il passo è stato breve. L’eroina è presto finita nelle mani del mercato nero, diventando un simbolo globale del “lato oscuro” della farmacologia. Oggi il suo uso medico è molto limitato e consentito solo in pochi Paesi.
- Metadone (una dose di metadone è circa tre volte più efficace della stessa dose di morfina): È più potente della morfina e possiede una durata d’azione molto lunga, che lo rende utile sia nel trattamento del dolore cronico sia nella terapia sostitutiva per la dipendenza da oppioidi. Tuttavia, può accumularsi nel corpo e richiede monitoraggio accurato.
- Idromorfone (5 volte più potente della morfina): Tra gli oppioidi più forti comunemente prescrivibili, è indicato nei casi di dolore acuto severo o quando altri oppioidi risultano inefficaci.
- Buprenorfina (da 25 a 100 volte più potente della morfina): Nonostante l’elevata potenza, è un agonista parziale, ossia si lega fortemente ai recettori oppioidi ma li attiva solo in parte. Questo riduce il rischio di overdose, rendendola ideale nei programmi di disassuefazione.
- Fentanyl (da 50 a 100 volte più potente della morfina): Oppioide sintetico estremamente potente, impiegato in anestesia e per il dolore oncologico. È molto efficace ma anche molto pericoloso se usato senza controllo.
- Sufentanil (fino a 1000 volte più potente della morfina): Ancora più potente del fentanyl, viene utilizzato esclusivamente in anestesia generale e in contesti ospedalieri altamente controllati.
- Carfentanil (diecimila volte più potente della morfina): È uno degli oppioidi più potenti conosciuti. Non è approvato per uso umano e viene impiegato solo in medicina veterinaria per sedare animali di grossa taglia, come gli elefanti. Bastano dosi infinitesimali, granelli di sale invisibili a occhio nudo, per provocare una depressione respiratoria fatale.
Effetti collaterali degli oppioidi
Nonostante siano essenziali nella gestione del dolore, i farmaci oppioidi presentano diversi effetti collaterali e rischi, soprattutto in caso di uso a lungo termine. La loro azione, infatti, coinvolge non solo i recettori del dolore, ma anche altri sistemi fisiologici, con conseguenze che possono variare a seconda del principio attivo utilizzato, del dosaggio e della durata del trattamento.
Tra gli effetti più comuni – e quasi inevitabili – c’è la stipsi indotta da oppioidi, dovuta alla riduzione della motilità intestinale, che spesso induce problemi sulla flora batterica (microbiota). Anche sintomi come euforia, sonnolenza, confusione mentale, nausea, prurito e ritenzione urinaria sono ben documentati dalla letteratura clinica.
Il rischio più temuto, però, è la depressione respiratoria, una condizione potenzialmente fatale che può insorgere soprattutto con oppiodi molto potenti, come fentanyl e sufentanil. Secondo i dati pubblicati dai CDC, acronimo di Centers for Disease Control and Prevention, agenzie federali americane che si occupano di salute pubblica, il fentanyl è oggi coinvolto in oltre il 70% delle morti per overdose da oppioidi negli Stati Uniti, proprio per la sua capacità di indurre rapidamente arresto respiratorio anche a dosi minime. Sono sufficienti, infatti, 3 milligrammi della sostanza per uccidere una persona.
La “droga degli zombie”
Spesso si sente definire il fentanyl come “droga degli zombie” a causa dei suoi potenti effetti sedativi sul sistema nervoso centrale, che possono causare sonnolenza estrema, confusione mentale e persino perdita di coscienza. Le persone che assumono dosi elevate possono sembrare quasi “zombie”, con movimenti lenti e difficoltà a reagire agli stimoli esterni. Non bisogna dimenticare però che effetti analoghi si hanno anche con altre tipologie di sostanze stupefacenti appartenenti alla stessa famiglia come l’eroina.
Un altro motivo per cui si parla del fentanyl come droga degli zombie è legata alla formazione di ulcerazioni profonde. Tuttavia, come ricorda l’Istituto superiore di sanità “né l’eroina tagliata col fentanyl né il fentanyl da solo sono la “droga degli zombie”. Si definisce tale una preparazione di eroina o di fentanyl tagliati con la xilazina, anestetico e miorilassante veterinario, al momento utilizzato pochissimo in Italia, ma impiegato invece dal mercato illecito per ottenere un taglio che dia più potenza alla preparazione a minor costo. La xilazina produce delle ulcere cutanee negli arti superiori ed inferiori, soprattutto dove avviene l’iniezione delle preparazioni di strada da eroina. Queste ulcerazioni profonde rendono i consumatori zombie: da qui il nome utilizzato per definire questa droga”.
Fentanyl, un dramma americano
La crisi degli oppioidi rappresenta per gli Stati Uniti la più grave emergenza di salute pubblica dal secondo dopoguerra. Questa epidemia, in continua evoluzione, ha visto un’escalation drammatica nell’abuso di farmaci oppioidi causando un numero allarmante di morti per overdose e sollevando interrogativi profondi sulla gestione delle dipendenze nel paese.
La crisi delle morti per overdose legate agli oppioidi è stata caratterizzata da distinte “ondate”.
- La prima, di fine anni ’90, è associata ad un aumento dell’utilizzo di oppioidi da prescrizione medica, con conseguente aumento delle dipendenze e dei decessi per overdose dovute a tali farmaci. Questa ondata è stata il risultato di un’azione sinergica di due principali attori. Da un lato le case farmaceutiche che hanno adottato pratiche promozionali aggressive e ingannevoli riguardo all’uso degli oppioidi (tra cui il tristemente famoso OxyContin o Ossicodone), spesso enfatizzandone benefici non supportati da evidenze di sicurezza ed efficacia. Dall’altro medici, alcuni dei quali compiacenti o corrotti, che hanno prescritto, in modo eccessivo e inappropriato, questi farmaci anche per trattare dolori lievi, spesso derivanti da comuni traumi sportivi. Il risultato di queste azioni è stato un aumento senza precedenti delle prescrizioni, dei disturbi da uso di oppioidi e dei decessi per overdose.
- La seconda ondata, del 2010, è il risultato di regolamenti più rigidi adottati per far fronte alle dinamiche che hanno generato la prima ondata. In particolare tali regolamenti avevano l’obiettivo di rendere maggiormente difficoltoso l’accesso ai farmaci oppioidi da prescrizione. I pazienti, che nel frattempo avevano sviluppato dipendenza per tali farmaci si sono così dovuti rivolgere al mercato nero ed a quanto in esso disponibile. Molti consumatori sono dunque passati all’utilizzo di eroina, più economica e accessibile; questo ha portato a un aumento delle morti per overdose legate a quest’ultima.
- La terza ondata, dal 2013 ad oggi, è caratterizzata dall’avvento sul mercato delle sostanze illecite di potenti farmaci oppioidi di origine sintetica, in particolare il fentanyl prodotto illegalmente, anche in combinazione con eroina, pillole contraffatte di varia natura. Le ricerche indicano che la comparsa di questi farmaci sul mercato nero è stata il risultato di cambiamenti nei prezzi e nella disponibilità di eroina, piuttosto che essere guidata da preferenze tra le persone che fanno uso di droghe. In effetti, col ritorno dei talebani al potere in Afganistan, questi ultimi hanno imposto tagli alla produzione portando di fatto ad una riduzione drastica della disponibilità di eroina a basso costo anche in Europa a partire dal 2024. La carenza di eroina dopo l’ultima repressione talebana all’inizio degli anni 2000 ha portato il fentanyl a mettere radici in Estonia, finora l’unica parte d’Europa ad aver dovuto affrontare un’epidemia duratura di dipendenza da questa sostanza.
Gli ultimi dati disponibili (ma provvisori) del National Vital Statistics System del Center for Diseases Control and Prevention (Cdc) indicano circa 87.000 decessi per overdose di droga da ottobre 2023 a settembre 2024, in calo rispetto ai circa 114.000 dell’anno precedente. Si tratta del minor numero di decessi per overdose in un periodo di 12 mesi da giugno 2020.
Sebbene questo declino nazionale sia una notizia incoraggiante, l’overdose rimane la principale causa di morte per gli americani di età compresa tra 18 e 44 anni, evidenziando l’importanza degli sforzi sostenuti per garantire che questo progresso continui.
Secondo le stime più recenti, 45 Stati hanno mostrato cali nei decessi per overdose, ma cinque (Alaska, Montana, Nevada, South Dakota e Utah) hanno comunque registrato aumenti, evidenziando la continua necessità di dati locali rapidi e di una risposta personalizzata. Oltre al grande calo provvisorio delle overdose fatali, si osservano anche diminuzioni minori delle overdose non fatali, come misurato dalle visite al pronto soccorso per overdose, e una continua diminuzione dell’uso di sostanze stupefacenti da parte dei giovani nelle auto-segnalazioni.
Molteplici fattori contribuiscono al calo dei decessi per overdose, tra cui la distribuzione diffusa e basata sui dati di naloxone, un farmaco salvavita che può invertire un’overdose; un migliore accesso a trattamenti per i disturbi da uso di sostanze; cambiamenti nell’offerta di droghe illegali; una ripresa della prevenzione e della risposta dopo le interruzioni legate alla pandemia; continui investimenti in programmi di prevenzione e risposta come il programma di punta Overdose Data to Action (OD2A) del Cdc. Infine, il Cdc finanzia la Overdose Response Strategy, un’innovativa collaborazione di dati sulla salute pubblica e sulla sicurezza pubblica in ogni Stato che consente ai professionisti della sicurezza pubblica come gli ufficiali delle forze dell’ordine di utilizzare i dati per comprendere meglio e intercettare le droghe illegali. Secondo il Cdc, ampliare l’accesso a trattamenti basati sull’evidenza per i disturbi da uso di sostanze, inclusi farmaci per i disturbi da uso di oppioidi come buprenorfina e metadone, è importante, oltre a creare più interventi guidati dalla comunità e promuovere l’istruzione e l’intervento precoce per prevenire i disturbi da uso di sostanze prima che inizino.
Prima di concludere, non si può non citare un nuovo studio pubblicato su Pediatrics[1] che lancia l’allarme sulle overdose mortali da oppioidi sintetici tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni negli Stati Uniti aumentate del 168% tra il 2018 e il 2022. Non sorprende che la maggior parte dei decessi sia causata dal solo fentanyl, che si conferma come sostanza più preoccupante sul mercato delle sostanze.
La situazione in Europa e in Italia
In Europa e in Italia, per fortuna, la situazione rimane più contenuta. Sebbene l’eroina resti l’oppioide illecito più diffuso, il passaggio verso l’uso illecito è stato relativamente limitato rispetto agli Stati Uniti. Tuttavia, anche nel Vecchio Continente si registra una crescente preoccupazione per la diffusione di oppioidi sintetici molto potenti, spesso coinvolti in intossicazioni acute e decessi. Secondo l’EMCDDA (l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze), negli ultimi anni si è assistito a un aumento delle segnalazioni di fentanyl e suoi analoghi in contesti non medici, soprattutto nell’Europa orientale e settentrionale.
In effetti, a partire dal 2012, l’EMCDDA ha segnalato un aumento significativo della presenza di fentanyl e dei suoi analoghi sul mercato illecito in Europa e quindi un aumento preoccupante dei decessi tra i consumatori di droghe legati all’uso di fentanyl. Nel 2021, gli Stati membri dell’UE hanno riportato all’EMCDDA 137 decessi associati al fentanyl di cui 88 registrati in Germania, 18 in Lituania, 9 in Austria, 6 in Danimarca, 6 in Finlandia, 4 in Estonia, 2 in Slovenia, 2 in Portogallo, 1 decesso in Ungheria e 1 decesso in Lettonia. E’ opportuno però sottolineare che il fentanyl è spesso rilevato in concentrazioni estremamente basse, il che ne rende complesso il rilevamento nella maggioranza dei laboratori clinici. Pertanto, i dati europei a oggi disponibili rappresentano probabilmente una sottostima del fenomeno. Principalmente questi oppioidi vengono importati, tuttavia, è stata segnalata anche la produzione di fentanyl in laboratori clandestini all’interno del territorio europeo (Nel 2023, Europol e Interpol hanno già individuato circa 400 laboratori clandestini in Europa, alcuni dei quali anche in Italia).
La lotta al traffico e allo spaccio di questi prodotti è resa molto complicata dalle caratteristiche intrinseche delle sostanze stesse. A causa della sua elevata potenza, infatti, è possibile trafficare quantità commercialmente significative di fentanyl o dei suoi analoghi con volumi molto ridotti. Sebbene attualmente la diffusione del fentanyl per uso non terapeutico in Europa sia relativamente limitata, questa sostanza rappresenta una potenziale minaccia che potrebbe avere un impatto significativo sulla salute e la sicurezza europea nel prossimo futuro. In Europa non si può comunque ancora parlare di un’emergenza fentanyl, ma l’attenzione sta crescendo, soprattutto perché la criminalità organizzata ha riconosciuto il potenziale business.
Ad oggi in Italia è stata emanata un’allerta di terzo grado per quanto riguarda il fentanyl, cioè una comunicazione di massima urgenza che viene mandata a tutti gli operatori che hanno a che fare con i consumatori di sostanze d’abuso. Nei destinatari di questa comunicazione ci sono: tossicologie forensi, forze di Polizia, il Ministero della Salute, l’Aifa, gli assessorati regionali alla Salute, i Pronto Soccorso, gli Ospedali. Negli alert, coordinati dal Dipartimento delle politiche antidroga, si avverte che c’è un’allerta sanitaria per i consumatori di droga. Negli ultimi anni, la diffusione del fentanyl in Italia sembra essere diventata più capillare. Tra il 2020 e il 2023, ci sono stati numerosi sequestri, tra cui uno particolarmente significativo a Piacenza. Nello stesso periodo, diverse inchieste hanno portato all’arresto di medici e farmacisti accusati di trafficare farmaci a base di fentanyl attraverso ricette false e furti nei magazzini. Nell’aprile del 2024, per la prima volta, tracce di fentanyl sono state trovate in una dose di eroina analizzata da un’unità di strada a Perugia. Al momento, in Italia c’è un piano nazionale di allerta sul fentanyl partito il 12 marzo 2024 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nonostante la crescente preoccupazione per l’abuso di fentanyl e altri oppioidi sintetici, le misure concrete adottate dal governo italiano finora sono state limitate. A differenza di alcuni paesi che hanno intrapreso interventi specifici e campagne di prevenzione mirate, in Italia manca un piano d’azione incisivo e coordinato per affrontare la minaccia emergente del fentanyl. Le politiche di contrasto si sono concentrate principalmente sull’aspetto repressivo e di controllo del traffico illegale, ma sono stati meno evidenti sforzi per aumentare la consapevolezza pubblica, migliorare l’accesso ai trattamenti per la dipendenza o promuovere iniziative di prevenzione su larga scala. L’assenza di una risposta proattiva potrebbe esporre l’Italia a un aumento del rischio legato agli oppioidi sintetici, soprattutto se consideriamo l’evoluzione della crisi in altri paesi.
Poiché tutti gli oppioidi, indipendentemente dal fine per cui vengono assunti – medico, terapeutico o illecito – finiscono per lasciare traccia nelle acque reflue, punto di raccolta invisibile ma rivelatore dei consumi collettivi, ricercatori dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri hanno condotto uno studio innovativo, incrociando le analisi chimiche delle acque reflue italiane con i dati ufficiali di prescrizione degli oppioidi. L’indagine, realizzata su scala nazionale e protrattasi per tre anni (2020–2022), ha preso in esame un insieme di sostanze oppioidi tra le più comunemente utilizzate. I risultati hanno evidenziato che in Italia gli oppioidi vengono consumati quasi esclusivamente per fini terapeutici e su prescrizione medica, senza indicazioni significative di un uso ricreativo sommerso. Una differenza importante rispetto agli Stati Uniti e ad alcuni Paesi del Nord Europa, dove le acque reflue raccontano storie molto diverse.
[1] Miller M, Wheeler-Martin K, Bunting AM, Cerdá M, Krawczyk N. Changes in Synthetic Opioid-Involved Youth Overdose Deaths in the United States: 2018-2022. Pediatrics. 2025 Jun 1;155(6):e2024069488. doi: 10.1542/peds.2024-069488. PMID: 40392279.